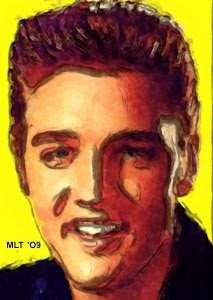giovedì 27 novembre 2008
Un buon anno per Charles
Quelle belle pantofole le aveva comprate dieci anni prima, a Philadelphia. Allora le cose erano molto diverse, il suo negozio di ferramenta fruttava bene, sempre all’avanguardia, sempre ben quotato, poteva dirsi soddisfatto, sereno e forse era, se non un uomo ricco, un vero benestante. Cos’era accaduto poi? Erano stati dieci anni difficili. Come era stato possibile un cambiamento così radicale? Come era arrivato ad essere persino incarcerato per debiti?
I suoi pensieri andavano ad un passato più remoto, si ritrovava ragazzino, a New Haven, nella vecchia fattoria di papà. Spesso, la sera, sedevano assieme sulla paglia, osservando il sole che tramontava sui campi. Con una piacevole mestizia ricordava il volto di suo padre, che con orgoglio gli raccontava le storie dei loro avi e di come avevano fondato e messo su la colonia.
La sua mente seguiva dei collegamenti casuali e, dal ricordo del fieno che pizzicava le caviglie, si ritrovava a ripensare di quando il papà, Aman, costruì il primo forcone d’acciaio, bello, resistente e innovativo. Al negozio di ferramenta Charles ne aveva venduti centinaia e mai nessun cliente si era detto insoddisfatto di quell’acciaio. Quell’acciaio tanto diverso da quello delle sbarre della cella in cui fu rinchiuso, dopo che il negozio era fallito ed erano falliti i suoi primi esperimenti con la gomma.
Ripensava a i suoi creditori e alla Roxbury, una società che aveva ideato una tecnica per fabbricare dei prodotti in gomma. Charles si era molto appassionato ai loro cataloghi e aveva ordinato diversi loro prodotti in gomma, ma in uno in particolare si era focalizzata la sua attenzione, un salvagente gonfiabile. Un’idea rivoluzionaria per l’epoca, ma c’era un particolare del salvagente che a Charles non piaceva, il tubicino per il gonfiamento. Studiate le proprietà della gomma e fatto qualche esperimento, riuscì a costruire un tubicino migliore. Così, convinto della bontà della sua idea, partì alla volta di New York per proporre la modifica alla Roxbury. Il direttore generale dell’azienda rimase impressionato dall’ingegno di Charles, tanto da dichiararsi interessato ad una collaborazione per altri progetti. Era un monito di speranza per Charles, una nuova strada si apriva davanti a se, avrebbe ripagato i suoi debiti e incominciato d’accapo. Tuttavia, la Roxbury, era in crisi finanziaria e propose a Charles un anno di sperimentazione del suo prodotto prima di poterlo lanciare sul mercato. Charles dovette aspettare molto meno per avere una risposta definitiva. La Roxbury ebbe un crack di lì a poco. Accadde, infatti, che la stragrande maggioranza della merce venduta dalla società tornò indietro, perché la debole gomma che era stata utilizzata si rovinava facilmente diventando inutilizzabile.
Di ritorno a Philadelphia quel farabutto di un suo creditore lo fece arrestare, ma la molla ormai era scattata nella sua testa. Dovunque si trovasse non poteva fare altro che pensare alla gomma. Lui sapeva che ci doveva essere un modo per rendere la gomma utilizzabile e duratura.
I problemi erano molteplici, questo materiale, infatti, estratto dagli omonimi alberi in Brasile e in India, è sì elastico e perfettamente impermeabile all’acqua, ma diventa appiccicoso già a 25 gradi e perde elasticità, indurendosi, a temperature non troppo basse. Bisognava trovare un modo per migliorarlo, serviva un’idea o un trucco per creare una gomma superiore.
La cella fu il suo primo laboratorio, si fece portare dalla moglie della gomma indiana, vari prodotti e attrezzi. Quei giorni di detenzione passarono rapidamente tra un esperimento e l’altro.
Gli anni che seguirono furono pieni di trasferimenti, prestiti, fallimenti, amici e creditori.
Aggiungendo alla gomma della magnesia era riuscito a renderla di un bel bianco, aggiungendo della fuliggine, sciogliendo il tutto in trementina e spalmandolo su un panno di flanella era riuscito a costruire il primo paio di scarpe impermeabili e con suola in gomma della storia. Un gran successo, all’inizio, ma si accorse presto che anche con questo trattamento le scarpe diventavano appiccicose, perdendo la fiducia dei suoi creditori che aspettavano pazientemente una rinascita finanziaria del promettente Charles.
Tra cantine come abitazioni, cene a base di pesci pescati al molo del porto, esperimenti falliti, un’intossicazione quasi mortale da acidi erano passiti dieci anni.
La sua mente vagava nei suoi ricordi e i suoi occhi si soffermavano ad osservare i vari oggetti della stanza. Oggettistica principale dell’arredamento, era la gomma. Charles teneva sott’occhio tutti i pezzi di gomma trattati nelle più svariate maniere. Li osservava, li tastava, li lasciava al sole per giorni, li schiacciava sotto la poltrona, li annusava e soprattutto, mettendo alla prova la pazienza della moglie, li disseminava per casa.
Un pezzo di gomma trattato con magnesio e bollito in calce viva e acqua era sopra una mensola di libri. Charles lo fissava, era stato quello il candidato sul quale aveva riposto più speranze, ma anche quel trattamento era fallito, bastava infatti che venisse a contatto con una sola goccia di acido per diventare immediatamente appiccicosissimo.
Dieci anni di frustrazioni, di miseria, di prove e bocciature. Charles era esausto. Sapeva che poteva farcela, doveva farcela, doveva trovare la soluzione. Ma non c’era! Aveva provato tutto, di tutto, acido nitrico, ossido di piombo, composti salini, ma niente. Non c’era verso. Quella maledetta gomma si teneva i suoi difetti.
Afferrò un pezzo di gomma trattato con della polvere di zolfo che giaceva da un paio di giorni su un tavolino. Un altro maledetto fallimento, anche in questo caso infatti la gomma restava sensibile alle temperature. Gettò amareggiato il pezzo di gomma in aria, in un gesto di sfogo, di liberazione, lasciando cadere indietro la testa e portandosi le mani sugli occhi. Maledetta gomma, pensava, maledetta gomma.
Mentre si massaggiava gli occhi, assorto in quei pensieri, un forte odore di bruciato riempì la stanza. Charles balzò in piedi cercando la causa dell’odore. Il pezzo di gomma zolfata era finito sulla stufa ed aveva preso fuoco. Afferrata una pinza da camino prese il pezzo in fiamme e lo gettò fuori dalla finestra, sulla neve, dove si spense all’istante.
La curiosità di un uomo che le ha provate tutte non poteva venir meno in quel momento. Infilatosi di corsa gli stivali corse fuori a raccogliere il pezzo bruciacchiato di gomma. Una volta raccolto notò subito una nuova consistenza del materiale, era più compatto. Il pezzetto non era ne appiccicoso ne troppo solido, fatto assai strano dopo che aveva preso fuoco e dopo che si era congelato un po’ sotto la neve.
Aveva trovato la soluzione!
Quella gomma era perfetta e Charles aveva appena inventato il processo di vulcanizzazione della gomma. La ricetta in fondo era semplice, aggiungere una parte di zolfo, cuocere il tutto e poi raffreddarlo repentinamente.
Ad oggi, con la stessa ricetta si sono fatte milioni di cose, tra cui gli importantissimi pneumatici!
Finalmente Charles poté dire, motivatamente, che era un buon anno per lui, un anno degno del suo nome, Charles Goodyear!
Nota disambigua.
La nota società di pneumatici Goodyear non fu fondata da Charles, ma porta il suo nome in suo onore. Charles, infatti, nonostante la scoperta, non ebbe fortuna avendo perso credibilità presso tutti i finanziatori. Non avendo il denaro per il brevetto cercò finanziamenti all’estero, spendendo pezzi di gomma vulcanizzata in Europa, soprattutto in Inghilterra dove un certo Hancock, anch’egli in cerca di un modo per lavorare la gomma, venne a conoscenza della vulcanizzazione di Goodyear e la brevettò a suo nome. La vicenda proseguì per vie legali, ma il povero Charles non la spuntò del tutto, riuscì tuttavia ad accaparrarsi altri brevetti, come quello per le scarpe che poi concesse ad una società francese, la Aigle. Nel 1855 l’imperatore di Francia, Napoleone III, conferì a Charles la croce della Legion d'Onore per servigi resi alla nazione. Croce che Goodyear ricevette in prigione, dove era stato nuovamente rinchiuso per debiti e sta volta con tutta la famiglia.
martedì 14 ottobre 2008
Per la fama o per la fame?
Lunedì 15 febbraio del 1512, poco prima dell’alba un ragazzo si sveglia di soprassalto. Seduto sul fatiscente letto che condivide con la sorella tende le orecchie e ascolta, senza capire. Con occhi sbarrati fissa la madre, i volti dei tre mostrano paura. Il ragazzo è magrolino, poco nutrito, vestito alla buona eppure è tale la paura che vorrebbe essere ancora più minuto e anonimo, vorrebbe sparire, portando con se la madre e la sorella. E’ un attimo e i tre si fiondano alla porta, urlando e tenendosi per mano escono in strada e iniziano una fuga disperata, verso un rifugio sconosciuto.
E’ guerra, e Brescia è una trappola. Non c’è via di fuga. Da due settimane i francesi assediano la città. Brescia, protetta dal popolo, ha appoggiato fino all’ultimo quell’atto di ribellione, ma la voglia di indipendenza verrà pagata a caro prezzo. I francesi non vogliono solo ripristinare il controllo, vogliono infliggere una punizione esemplare agli insorti.
I tre intanto si sono uniti ad altri uomini in una fuga disperata. Imboccano stradine e vicoletti cercando di sfuggire alle truppe. Ma incappano in un vicolo cieco, sono circondati. “Niccolò, Niccolò!” Urla la madre, stringendo la mano dell’altra figlia, ma Niccolò è distante, in testa al gruppetto. Faccia a faccia con le truppe che gli corrono incontro, non ha neppure il tempo di voltarsi per fuggire che un soldato gli è addosso, spada sguainata mira al volto. Il ragazzo cade e altri due colpi alla testa e alla mandibola lo straziano.
Va meglio alle due donne, ma Niccolò è in una pozza di sangue, il volto irriconoscibile, maciullato e trapassato. Tra le urla della madre, che lo stringe al petto imbrattando di sangue del figlio la veste e il viso, il mondo sembra finire. Qual è la logica della vita di fronte alla morte? Quale soluzione potrebbe cercare una madre alla perdita di un figlio? Quale altra sciagura, dopo la morte del marito, deve subire la donna...
Io credo che una dose di fortuna debba toccare a tutti, ma che a pari fortuna debba sempre corrispondere una pari dose di sfortuna. Una equazione che vale sempre. Fu così che un uomo tanto povero da non poter andare a scuola godette invece di una altrettanta dose di genio e che sempre quell’uomo, quel ragazzo stretto al dolore di una madre, esaurì in quel momento, forse, l’intera sua dose di fortuna.
Un gemito impercettibile, ma tanto potente da zittire per un istante le urla della donna, che ora fissa con occhi gonfi il ragazzo. Un nuovo segnale, un lamento… Niccolò è ancora vivo!
Solo grazie alle cure della madre Niccolò nei mesi successivi si rimette, ma la sua mandibola è compromessa. All’inizio non poteva neppure mangiare, ma adesso riesce anche a parlare, seppure balbettando.
Questo difetto se lo porterà per tutta la vita. Gli amici lo ribattezzeranno Tartaglia e lui, sdrammatizzando, accetterà il nomignolo adottandolo come cognome.
Niccolò Fontana, detto Tartaglia, divenne un matematico… e che matematico! Le sue origini modeste non gli permisero di frequentare la scuola, tuttavia la madre riuscì a pagare un maestro privato che gli insegnò la scrittura delle lettere. Arrivati alla lettera “k”, tuttavia, le finanze si esaurirono e Tartaglia dovette abbandonare le lezioni. Continuò da autodidatta fino alla “z” e proseguì studiando tutto lo scibile dell’epoca sulla matematica e sulla fisica.
Tanto incerto era nel parlare quanto con lucidità e maestria era abile nel ragionare. Le sue umili condizioni lo aizzavano a dimostrare le sue capacità di fronte a coloro che avevano raggiunto il suo livello pur non patendo tali sofferenze e frustrazioni.
Tra Verona e Venezia, città nelle quali visse e insegnò, conobbe molti matematici. A quel tempo per far carriera nel campo delle scienze bisognava dimostrare di essere unici, geniali, così da tentare di essere assunti da qualche mecenate. Per questo fine, se qualcuno scopriva qualcosa degna di nota, come una legge fisica o un metodo matematico, si guardava bene dal divulgarla, così da poter dire in giro di essere l’unico a conoscerla.
Si racconta che Tartaglia avesse conosciuto un certo Anton Maria Fiore, mediocre matematico che si spacciava capace di risolvere equazioni di terzo grado. Risolvere tali equazioni, a quel tempo, non era un problema tanto semplice, dato che ancora non si era scoperto alcun metodo risolutivo e, a complicare tutto, non si conoscevano ancora i numeri complessi e non si erano analizzate le proprietà dei numeri negativi. Fiore rappresentava per Tartaglia una sfida da non poter mancare.
Fu così che Niccolò studiò a fondo il problema, ragionò e provò, ma il compito era davvero molto arguto. Istigato dal dover dimostrare le sue capacità, finalmente, ricavò una soluzione generale per equazioni di terzo grado. Nascosti gli appunti in luogo sicuro si apprestò a preparare la sua sfida.
In quegli anni i matematici si sfidavano tramite cartelli di matematica diffida. Ogni contendente proponeva un certo numero di quesiti all’avversario, generalmente 30, che doveva risolverli entro un tempo prestabilito. Ogni cartello veniva depositato presso un notaio, stampato e poi divulgato nelle comunità di studiosi. Alcuni giudici, scelti di comune accordo, valutavano le risoluzioni dei problemi e dichiaravano vincitore colui che era riuscito a risolverne di più e in minor tempo.
Tartaglia iniziò a divulgare la notizia che lui aveva trovato la soluzione al problema delle equazioni di terzo grado e mise in dubbio l’effettiva esistenza e validità di un’analoga soluzione attribuibile a Fiore. Nel febbraio del 1535 Fiore inviò un cartello di matematica diffida a Tartaglia, che accettò prontamente.
Lo scontro fu memorabile, e sicuramente quella diffida è la più famosa che sia mai avvenuta. Fiore propose a Tartaglia 30 equazioni di terzo grado e altrettante ne ricevette da risolvere. Dopo due ore Tartaglia aveva risolto tutti i quesiti, ma non sarebbe bastato un anno intero affinché Fiore ne risolvesse solo uno di Tartaglia.
Ma perché allora Fiore sfidò Tartaglia?
Fiore di certo non aveva mentito, avendo più e più volte dimostrato di saper risolvere problemi di terzo grado.
Vent’anni prima l’insegnate di Fiore, Scipione Del Ferro, aveva effettivamente trovato una soluzione alle equazioni di terzo grado, ma non si decise mai a divulgarla. Solo su letto di morte, rivelò al suo allievo la sua scoperta. Fiore, tempo dopo, rivendicò il patrocinio del metodo immeritatamente. Ma allora perché non riuscì a risolvere i problemi propostigli da Tartaglia?
Il fatto fu che Del Ferro comunicò a Fiore una soluzione valida solo in un caso particolare di equazioni di terzo grado, Tartaglia invece ricavò una soluzione generale valida in ogni caso. Notando che Fiore proponeva solamente soluzioni per equazioni di un certo tipo gliene propose 30 di tipo differente.
La vittoria diede una certa notorietà a Tartaglia, ma la tanta auspicata chiamata da parte un qualche mecenate non arrivava. C’è da ricordare inoltre che Tartaglia, pur essendo un grande matematico aveva serie difficoltà a mantenere i posti da insegnate che gli venivano proposti a causa del suo problema di balbuzie.
La discreta fama che si susseguì dalla disputa portò Tartaglia alla conoscenza di un influente medico e studioso milanese, Girolamo Cardano, che iniziò a “corteggiare” il matematico. Con la promessa di trovargli un mecenate a Milano, Cardano supplicava Tartaglia di rivelargli il metodo risolutivo. Niccolò era di fronte ad una scelta, pubblicare il metodo così da ufficializzare la paternità della scoperta, oppure non divulgarla rendendosi più appetibile agli occhi dei facoltosi mecenati milanesi. L’influenza di Cardano però era un fattore non trascurabile per poter trovare un posto nella ricca città.
Cardano giurò di non divulgare mai la sua scoperta e Tartaglia gli spedì una poesia celante la soluzione tanto desiderata, soluzione che fu trovata a Venezia, “nella città dal mare intorno centa”:
Quando che 'l cubo con le cose appresso
se agguaglia a qualche numero discreto
trovan dui altri differenti in esso.
Da poi terrai questo per consueto
che il loro produtto sempre sia eguale
al terzo cubo delle cose netto,
El residuo poi suo generale
delli lor lati cubi ben sotratti
varrà la tua cosa principale.
In el secondo de codesti atti
quando che 'l cubo restasse lui solo
tu osserverai quant'altri contratti,
Del numero farai due tal partà volo
che l'una in l'altra si produca schietto
el terzo cubo delle cose in stolo
Dalla qual poi, per commun precetto
torrai li lati cubi insieme gionti
et cotal somma sarà il tuo concetto.
El terzo poi de questi nostri conti
se solve col secondo se ben guardi
che per natura son quasi congionti.
Questi trovai, et non con passi tardi
nel mille cinquecente, quatro e trenta
con fondamenti ben saldi e gagliardi
Nella città dal mare intorno centa
Questa poesia fu la dose di sfortuna che pareggiava i conti con la miracolante fortuna che lo tenne in vita quella mattina del 1512.
Cardano, infatti, in un primo momento mantenne il giuramento. Tempo dopo, però, scoprì che Fiore aveva saputo la soluzione da Del Ferro, quindi rintracciò il genero di Del Ferro che gli permise di dare uno sguardo alle carte del suocero. Cardano scoprì che Del Ferro non aveva solo scoperto la soluzione del caso particolare comunicato a Fiore, ma anch’egli era giunto a una soluzione generale.
Non sentendosi quindi più vincolato dal patto con Niccolò Fontana pubblicò in un trattato il metodo risolutivo, specificando tuttavia che lo aveva ricevuto dal Tartaglia.
Tartaglia andò su tutte le furie e iniziò una contesa legale che durò più di dieci anni. In un trattato Niccolò apostrofò con parole dure Cardano, denunciando la violazione del giuramento che quest’ultimo gli aveva fatto. Un allievo di Cardano, Ludovico Ferrari, in difesa del suo amico e professore inviò a Tartaglia sei cartelli di sfida in due anni. Ferrari impose delle dispute verbali, mettendo in difficoltà Tartaglia che, con i suoi problemi di parola, non riusciva a fare meglio dell’avversario. In aggiunta le dispute si tennero tutte a Milano dove il Ferrari godeva di molte amicizie.
Il 10 Agosto 1548 si tenne l’ultima disputa conclusasi con la sconfitta di Tartaglia, a cui non fu permesso di poter esporre le proprie ragioni. Tornato a Brescia, dove aveva da poco trovato un posto come insegnate, trovò ad aspettarlo il licenziamento.
Con difficoltà finanziarie e senza mai trovare un lavoro fisso Niccolò Tartaglia non riuscì mai ad avere successo. Il suo metodo risolutivo oggi è noto come “formula di Cardano-Tartaglia” avendo, i posteri, attribuito al medico parte del merito. Oltre al secondo posto nel nome della formula quella poesia costò a Tartaglia anche l’aver fatto venire alla luce l’esistenza della soluzione antecedente di Del Ferro che ne minimizza il prestigio.
Beffa volle che Tartaglia riscoprì numerosi metodi e sistemi matematici, come il famoso triangolo di Tartaglia, che con il tempo si scoprì che altri, in altri luogo del mondo e prima di lui avevano già scoperto.
Tuttavia il suo nome è giunto fino a noi ripagando una vita di fame con una fama immortale.
martedì 23 settembre 2008
Sul fiume Hudson...
Ricordo che è capitato anche a me. Da piccolo, in un viaggio con i miei. Da una cabina telefonica sgangherata, in Olanda, forse, telefonavamo alla nonna. Lei parlava forte ed io di rimando, come a colmare una distanza troppo grande. Grati, nondimeno, della magia del telefono che, anche a tali distanze, ci collegava come sempre.
E’ vero che se i telefoni che comunicano tra loro sono posti a forte distanza la voce si sentirà più flebile? Ed è vero che gli anziani hanno spesso l’abitudine di parlare a telefono a voce alta?
Forse, fino a pochi decenni fa, era vero che larghe distanze attenuassero l’intensità del segnale vocale, bastavano anche poche decine di chilometri per attenuarlo sensibilmente. Credo che sia per questo motivo che mia nonna, come tante altre nonne, tenda a parlare forte al telefono quando sa che chi parla è a molta distanza (complici anche l’età e l’abbassamento dell’udito!).
Oggi, tuttavia, questo problema della distanza è superato. Un tempo, infatti, il segnale vocale veniva trasformato attraverso il microfono della cornetta in un segnale elettrico, un segnale analogico, e veniva amplificato e trasmesso così com’era lungo i cavi telefonica. Se durante il tragitto doveva attraversare lunghe tratte poste tra delle centraline allora esso veniva amplificato ogni volta e ritrasmesso. La trasmissione di un segnale, infatti, non è un’operazione semplice, durante la propagazione il segnale subisce delle attenuazioni e se non amplificato non potrebbe coprire le distanze richieste.
Oggi, nell’era digitale, se il segnale telefonico deve attraversare lunghe tratte o passare dallo spazio, viene digitalizzato, ovvero convertito in una sequenza di 1 e di 0. Diviene un codice! Quel codice all’occorrenza verrà ritrasformato nel segnale originario e al volume desiderato! Inoltre per trasmissioni digitali non possiamo proprio dire di ricevere un segnale “troppo attenuato”, o lo si riceve o non lo si riceve. Tuttavia anche il segnale digitale ha bisogno di essere trasmesso forte e chiaro per evitare errori dovuti ad attenuazioni. Insomma tutti i segnali per essere trasmessi devono essere amplificati.
Fin dagli albori della telefonia, senza amplificatori in grado di aumentare la forze dei segnali, nessuno, urlando o no, avrebbe potuto effettuare una telefonata. In modo che tutti possano capire, si può pensare ad un amplificatore come ad una scatoletta con un foro d’ingresso e uno d’uscita, se si parla in un foro la voce esce ad un volume più elevato dall’altro.
Nel 1927, una compagna telefonica americana, che oggi si chiama Bell, studiava nei propri laboratori un sistema per la comunicazione telefonica a grande distanza. L’obbiettivo era di realizzare degli apparati che permettessero un collegamento efficiente tra le due coste degli Stati Uniti e tra l’America e l’Europa.
Uno degli ingegneri che lavoravano al progetto si chiamava Harold S. Black. Aveva 29 anni e da sei lavorava come ricercatore. Black doveva trovare un modo per migliorare le prestazioni degli amplificatori posti come ripetitori sulle linee telefoniche in modo da trasmettere simultaneamente più segnali a lunghe distanze.
Tali livelli di amplificazione infatti determinavano delle distorsioni eccessive del segnale. Come se la voce dalla nostra scatola uscisse fortemente amplificata ma del tutto incomprensibile. Anche riuscendo ad ottenere delle distorsioni accettabili le caratteristiche tecnologiche di quegli amplificatori li rendevano soggetti a forti variazioni del loro funzionamento, variazioni causate dai cambiamenti di temperatura e dall’invecchiamento.
Black cercava di perfezionare quegli amplificatori, inseguendo l’utopico desiderio dell’amplificatore perfetto, ma si rendeva conto nel contempo che produrre un amplificatore quasi perfetto era forse possibile, ma mantenerlo tale nel tempo e produrne tanti in larga scala era impensabile.
Gli amplificatori di oggi sono molto diversi da quelli usati nel 1927, ma Black di certo non poteva sperare di realizzare un amplificatore diverso da quello che si conosceva allora. Così come oggi non possiamo immaginare come saranno gli amplificatori del futuro.
No, posso asserire che Black non desiderava inventare un amplificatore che non avesse i problemi degli amplificatori di allora. Black era in cerca di un’Idea.
Un'idea semplice che potesse risolvere il problema senza stravolgere troppo il sistema su cui si stava lavorando. Un'idea economica e facile da realizzare. Un'idea che forse lui sapeva di poter avere.
Era il 2 agosto 1927 ed era mattina. Black si avviava, armato di valigetta, verso il battello Lackawanna sul fiume Hudson. Black prendeva il battello tutte le mattine per recarsi al lavoro a Manhattan. Prima di imbarcarsi, come sempre, comprò il New York Times e stretto sotto al braccio si avviò sul ponte in cerca di una panchina. Quella mattina fissava come sempre col capo chino quella prima pagina di giornale, senza però riuscire a leggere i titoli degli articoli. Quella mattina Black era assorto nei suoi pensieri. Black era alla ricerca della sua Idea.
Fu un gesto automatico che nessuno notò, che nessuno capì fino in fondo per quello che era, che suscitò forse per qualche secondo la curiosità del suo vicino di seduta, ma nulla più. Black sfilò del taschino una matita e schizzò su quella prima pagina un diagramma.
Il diagramma mostrava il disegno di un normale amplificatore il cui cavo d’uscita veniva riattaccato ad un cavo d’ingresso.
Per tornare all’esempio della nostra scatola, immaginate di far rientrare con un tubo la voce dal foro di uscita al foro di ingresso.
Il diagramma mostrava un amplificatore retroazionato negativamente.
Black ricavò velocemente le proprietà fondamentali di quello schema. Giunto alla fine dei suoi conti ebbe un sussulto. Il cuore gli batteva all’impazzata. Aveva avuto la sua Idea.
Firmò immediatamente i suoi appunti in fondo alla pagina del giornale e, appena arrivato in laboratorio corse dal suo direttore Blessing mostrandogli il quotidiano. Questi convintosi dell’importanza dell’invenzione firmò anch’egli a piè pagina quale testimone.
La trovata fu mirabolante per lo sviluppo tecnologico del secolo scorso. Il 29 dicembre dello stesso anno Black verificò sperimentalmente per la prima volta le caratteristiche dei sistemi retroazionati negativamente, misurando una riduzione della distorsione di un fattore 100.000 sui segnali vocali, utilizzando così il primo amplificatore retroazionato della storia.
martedì 16 settembre 2008
Marketing virale
Chissà quante catene di sant’Antonio con richieste come questa ricevo ogni giorno tra le mie caselle e-mail, il pensare poi che alcune fanno il giro del mondo e vengono tradotte in decine di lingue, rimaneggiate, criptate, travisate, sfruttate e anche censurate dai governi, mi sbigottisce.
Mi sbigottiscono le migliaia di copie che vengono inviate nella rete e mi sbigottisce il tempo brevissimo con il quale si moltiplicano. Come ciò sia possibile mi è perfettamente chiaro, ciò che mi incuriosisce di più è il sapere che da qualche parte, chissà quanto tempo prima, qualcuno il cui aspetto, sesso, età e nazionalità resteranno per sempre sconosciuti, ha scritto una prima e-mail e l’ha inviata a qualche conoscente decretando così un Inizio.
Il marketing virale è una forma di comunicazione pubblicitaria (a fini di lucro e no) basata sul passaparola. Un’idea originale, riesce, grazie alla sua natura o al suo contenuto, ad espandersi rapidamente su una data popolazione, sfruttando le capacità comunicative dei suoi componenti.
Grazie all’e-mail facciamo parte ogni giorno di un numero incalcolabile e imprevedibile di cicli di marketing virale e la loro efficacia è garantita dalla facilità e rapidità del mezzo.
Poco più di tredici anni fa, tuttavia, l’e-mail non era così diffusa, anzi non lo era per niente, per non dire che era quasi sconosciuta. Solo l’imprenditoria e la ricerca ne facevano uso e, per farne, bisognava pagare.
L’imprenditore Draper Fisher Jurvetson possedeva già un indirizzo e-mail quando, dopo averne inviata una di auguri natalizi a un suo collega ricevette nel suo studio Sabeer Bhatia e Jack Smith.
Era il 1995 e Sabeer aveva appena compiuto 27 anni, dall’india si era trasferito negli stati uniti qualche anno prima, sicuramente in quel momento si sentì felice di aver fatto quella scelta. Di Jack, purtroppo, ne so poco. Jack e Sabeer si conobbero alla Apple, nella quale entrambi erano impiegati.
Jurvetson era noto già allora per la sua politica di appoggiare e finanziare ogni sorta di idea che riguardasse Internet, quella che sentì quella sera forse fu la prima delle migliori che ha sentito fino ad oggi.
Sabeer e Jack gli proposero di sviluppare un servizio gratuito di e-mail basato sul Web. L’idea era di fornire un account a chiunque lo volesse e di rendere gli account accessibili dal Web. Tramite la gestione del proprio account via Web, chiunque avesse accesso ad Internet avrebbe potuto possedere e usare un’e-mail senza pagare e senza essere dotato di alcun software specifico. La trovata, inoltre, permetteva anche molta mobilità, da qualunque parte del modo e su qualunque computer sarebbe stato possibile leggere e inviare la propria posta e consultare il proprio archivio.
Ma dove stava il guadagno?
Nella pagina Web con la quale si consultava la propria posta sarebbero apparsi dei banner pubblicitari. Se l’idea avesse funzionato si potevano prevedere forti guadagni con la vendita di quegli spazi.
In cambio del 15% della loro compagnia, Draper Fisher Jurvetson finanziò Bhatia e Smith, che fondarono una società chiamata Hotmail.
Con tre persone a tempo pieno e una dozzina part-time che lavoravano in cambio di azioni svilupparono il servizio in soli sei mesi lanciandolo nel luglio del 1997.
Dopo solo un mese si contavano già 100.000 iscrizioni e la crescita era esponenziale.
Nel dicembre del 1997 gli iscritti erano più di 12 milioni e, dopo 18 mesi dal lancio e solo 2 anni da quella fatidica sera, Microsoft acquisiva Hotmail sborsando 400 milioni di dollari.
L’avere avuto prima di chiunque altro l’idea e l’averla realizzata rapidamente è stato il fattore vincolante per il successo di questi uomini. Anche se altre società abbiano immediatamente copiato l’idea, quel vantaggio di sei mesi sulle altre è bastato per mantenere un distacco decisivo.
Con i guadagni Jurvetson finanziò negli anni a seguire numerose idee brillanti, piazzandole sempre per svariati milioni di dollari ai migliori offerenti. Tra i clienti di Jurvetson incontriamo Yahoo, che ha acquistato dal lui Overture, e eBay che ha comprato Skype per poco più di due miliardi e mezzo di dollari.
sabato 13 settembre 2008
Quanto diamo per scontato.
Dare per scontato è una necessità, se ci chiedessimo il motivo o il come di ogni cosa, non ci basterebbero diverse vite solo per porci le domande. Tuttavia stupirsi di nulla è sinonimo di ozio e di inoperosità. L’uomo nella sua pigrizia è felice il primo giorno, ma inizia ad avvizzire il secondo.
In qualsivoglia tempo della storia dell’umanità, gli uomini hanno sempre dato per scontato quegli oggetti di uso quotidiano frutti, in realtà, dell’ingegno di altri che li hanno pensati o che li hanno scoperti.
Per chiunque è un fatto assolutamente normale osservare un’automobile muoversi, o un aereo volare, o aprire un rubinetto e sentirsi bagnare da linda acqua calda, o accendere un televisore e vedere!
Tutte cose che poco più di un secolo fa, erano impensabili o irrealizzabili. E’ stata la ricetta del progresso a guidare l’uomo ai giorni nostri, gli ingredienti principali sono sempre gli stessi: caso, ingegnosità, necessità, curiosità, forse denaro e poco più.
Un po’ per carattere un po’ studiando ingegneria, mi ritrovo spesso a domandarmi sul come possano funzionare determinati oggetti, o su chi sia riuscito a trovare per primo la soluzione ad un determinato problema e in che modo(!), a come certe idee rivoluzionarie o geniali siano venute in mente ai loro ideatori.
Questi quesiti mi hanno portato a collezionare storie di uomini speciali, di uomini fortunati, che hanno avuto la capacità o la sorte di contribuire al progresso. Come è giusto che sia, ogni storia è del tutto singolare e mai scontata e ho deciso di raccontarle, una ad una e tutte insieme in questo blog.
Sarà una sorta di club, una comitiva delle idee e dei progetti arguti dell’ingegneria che mi tengono compagnia e mi incoraggiano nella speranza di entrarne a far parte, un giorno, anch’io.
Buona lettura.